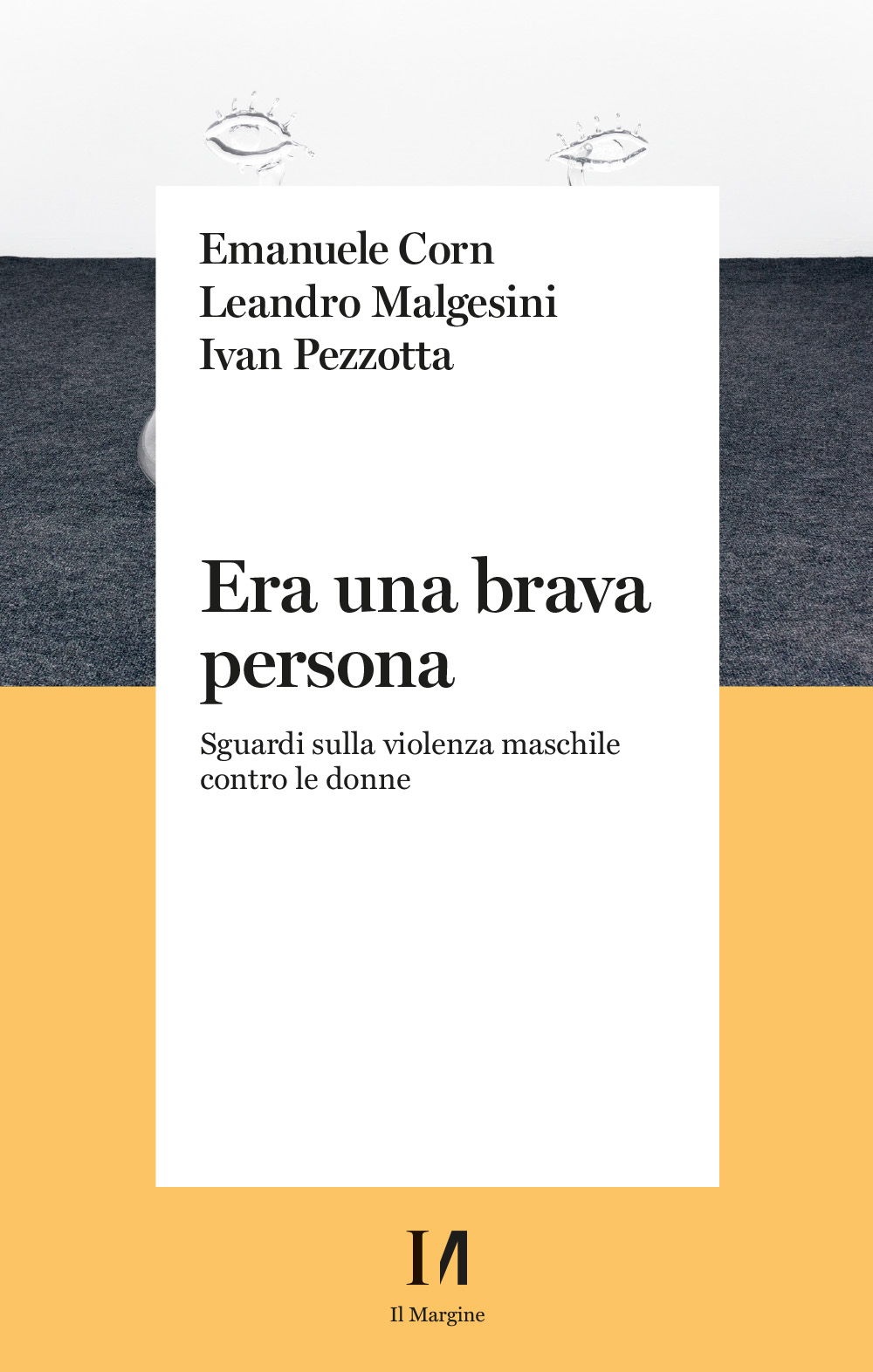«Era una brava persona»: cambiare lo sguardo sulla violenza contro le donne
Cosa ci dicono le storie degli uomini autori di violenza. In dialogo con Ivan Pezzotta psicologo e psicoterapeuta.
Ogni volta che una donna viene uccisa,le frasi che circolano sono quasi sempre le stesse: “Era una brava persona” oppure “Era un mostro”. Due immagini opposte che hanno però un effetto simile: spostano la violenza fuori dal nostro campo visivo. Nel primo caso come qualcosa di inspiegabile che irrompe nella vita di una coppia normale, nel secondo come gesto di qualcuno radicalmente altro da noi, disumano, che ci permette di sentirci al sicuro.
Il dottor Ivan Pezzotta è coautore, insieme a Emanuele Corn e Leandro Malgesini, del libro «Era una brava persona. Sguardi sulla violenza maschile contro le donne», un saggio che ci invita a fermarci proprio qui, in questo punto cieco. A chiederci cosa ci stiamo perdendo quando riduciamo tutto al racconto del mostro o del raptus. E che cosa possiamo vedere in più se partiamo, invece, dalle storie concrete degli uomini autori di violenza e delle donne che quella violenza la subiscono. Pezzotta lavora da anni nel percorso CambiaMenti, della Rete Operativa Servizi Antiviolenza, e da qui siamo partiti per questa intervista pensata in modo specifico per la newsletter di Vales.
Che cos’è CambiaMenti
Cambiamenti è un percorso, non un corso. Un percorso socio-psico-educativo rivolto a uomini che hanno agito, o sono a rischio di agire, violenza contro la propria partner o ex partner.
L’obiettivo è chiaro: la sicurezza della donna attraverso il lavoro sull’uomo. Significa offrire all’uomo la possibilità di prendere consapevolezza della responsabilità dei propri agiti e di imparare strategie concrete per non ripeterli.
Non è uno spazio di auto assoluzione, né un luogo in cui semplicemente ci si sfoga per “stare meglio”. È un lavoro strutturato, con tempi, regole, valutazioni e una rete di servizi intorno.
Oltre il raptus: violenza, potere e cultura
Nel saggio Pezzotta torna più volte un punto chiave: la violenza non è solo un’esplosione di rabbia. La rabbia è spesso l’emozione visibile, ma al centro c’è il modo in cui viene esercitato il potere nelle relazioni.
La violenza è un modo, più o meno consapevole, di mantenere o ristabilire controllo quando l’uomo percepisce minacciata la propria posizione nella coppia, nella famiglia, nello sguardo degli altri uomini. Per questo esiste violenza anche senza urla o percosse, nelle forme psicologiche, economiche, sessuali.
C’è poi il tema dell’infanzia e dell’attaccamento: crescere in contesti in cui le emozioni sono riconosciute e accolte aiuta a non usare la violenza come unica lingua possibile della paura o della vergogna. Crescere in contesti in cui a un maschio è concesso quasi solo essere forte e arrabbiato espone molto di più al rischio di usare il controllo come risposta alla frustrazione.
Tutto questo non serve a giustificare la violenza ma a fare da sfondo alle domande più concrete che abbiamo posto a Pezzotta sul lavoro con gli uomini autori di violenza.
Vales: Nei percorsi di riabilitazione per uomini autori di violenza, qual è secondo te il punto di equilibrio tra responsabilizzazione individuale e riconoscimento dei fattori culturali e strutturali che sostengono il potere maschile nelle relazioni?
Ivan Pezzotta: Questo è forse il punto principale, nel senso che esistono entrambi gli elementi. Noi, nel percorso CambiaMenti, facciamo quello che si chiama prevenzione terziaria: interveniamo quando la violenza è già stata agita, quando la nave sta già andando a picco.
L’intervento sui fattori culturali e strutturali invece appartiene soprattutto alla prevenzione primaria e in parte secondaria. È lì che bisognerebbe incidere di più: sui modelli, sugli stereotipi, sulle norme implicite che rendono certe forme di potere maschile così normali da diventare invisibili.
Alcune situazioni di rischio probabilmente emergerebbero comunque, ma in una società che sa leggere le dinamiche della violenza queste situazioni vengono riconosciute prima, intercettate prima e arrivano a un’escalation meno rapida e meno distruttiva.
Valutare se iniziare un percorso: da dove si parte
Vales: In termini molto concreti, quali sono le tappe che non possono mancare in un percorso di trattamento per un uomo autore di violenza e come capite se l’assunzione di responsabilità non è solo linguistica, di facciata, ma sta diventando un cambiamento reale?
Ivan Pezzotta: La prima fase è sempre una fase di valutazione. Facciamo tre, quattro, talvolta cinque colloqui solo per capire se ci sono le condizioni minime per iniziare: se non c’è un’assunzione di responsabilità, anche molto piccola ma autentica, noi non prendiamo la persona in carico.
Il riconoscimento di facciata lo si vede: quando è solo strumentale, quando serve a mostrare la versione giusta per il giudice o per i servizi, non è un buon punto di partenza. Quando invece cogliamo anche una piccola parte vera, quella diventa il nostro ancoraggio, la base su cui lavorare.
Nel percorso poi lavoriamo sì sulla gestione della rabbia, ma soprattutto sul significato della violenza come strumento di potere e controllo. In modo trasversale, in tutte le sessioni, lavoriamo sugli stereotipi di genere e sulla gestione emotiva in generale, perché spesso dietro la rabbia ci sono paura, tristezza, disperazione.
Affrontiamo anche il tema della sessualità, del desiderio, del modo in cui viene gestita la sessualità nella relazione, la comunicazione, i conflitti. I punti principali a mio avviso sono proprio la gestione emotiva e gli stereotipi di genere, ma lavoriamo parecchio anche sulla genitorialità.
Narrazioni manipolative e rischio di vittimizzazione secondaria
Vales: Come si lavora, nei vostri percorsi, sul tema della narrazione che l’uomo fa di sé e della partner, per evitare che la riabilitazione si trasformi in una forma più sofisticata di vittimizzazione secondaria o di controllo emotivo sulla donna?
Ivan Pezzotta: Le narrazioni autoconsolatorie o vittimistiche vengono gestite con molta attenzione. CambiaMenti non è un gruppo di auto mutuo aiuto, è un gruppo condotto da due professionisti con formazione ed esperienza specifica, proprio per poter intervenire su questo piano. Quando un uomo usa il gruppo per confermare la propria auto assoluzione, se riteniamo che possa reggere il confronto, lo mettiamo direttamente di fronte alle sue contraddizioni. A volte sono gli stessi partecipanti a farlo, dicendogli apertamente che ciò che sta raccontando non torna. Se questo non è possibile in quel momento non forziamo, andiamo avanti con il programma e ritorniamo su quei temi più avanti, lavorandoci per gradi.
In più abbiamo uno strumento decisivo, che è il contatto partner: una figura esterna al percorso che mantiene il contatto con la donna. Serve proprio a evitare la strumentalizzazione del percorso.
Fin dal primo contatto diciamo chiaramente alla donna che il fatto che lui frequenti il percorso non è una garanzia di sicurezza. La violenza è responsabilità di chi la agisce, non di chi la subisce. Questo va detto con grande chiarezza. Il contatto partner è la chiave per ridurre il rischio di vittimizzazione secondaria.
Lingua giusta o cambiamento reale
Vales: Esistono indicatori, anche imperfetti, che aiutano a distinguere un uomo che sta davvero modificando il proprio assetto di potere nelle relazioni da chi ha semplicemente imparato il linguaggio corretto sulla parità e sul consenso?
Ivan Pezzotta: Gli indicatori non sono mai perfetti, ma qualcosa si può vedere. Guardiamo la partecipazione al gruppo, il modo in cui una persona si espone, la coerenza tra ciò che dice e ciò che riemerge nel tempo. Quello che non è elaborato, in un gruppo, prima o poi emerge. Per quanto uno possa raccontarsela molto bene, qualcosa sfugge. Siamo in due a condurre, osserviamo da angolature diverse, e spesso sono gli altri uomini del gruppo a far emergere le contraddizioni.
Paradossalmente sarebbe più facile “fregarci” in una terapia individuale che in un percorso di gruppo. Nella relazione uno a uno un uomo può costruire una narrazione molto controllata, nel gruppo è più difficile mantenere a lungo una facciata.
Non sempre abbiamo prove oggettive di ciò che sentiamo, ma spesso ci accorgiamo che qualcosa non torna. E qui torna centrale, ancora una volta, il contatto partner: è fondamentale per capire come vanno davvero le cose a casa.
Ricordo, per esempio, un uomo che in gruppo lavorava apparentemente molto bene: si metteva in discussione, partecipava, interveniva. Poi, a casa, la situazione era disastrosa, non capitalizzava nulla di quello che elaborava negli incontri. Abbiamo dovuto intervenire in modo netto perché il livello di rischio restava alto. Lo abbiamo capito grazie al contatto partner e a ciò che, a un certo punto, è emerso nel confronto con gli altri uomini.
Limiti etici e clinici: cosa non delegare ai percorsi
Vales: Quali sono, secondo te, i limiti etici e clinici dei percorsi per uomini autori di violenza e cosa sarebbe importante che servizi, centri antiviolenza e istituzioni sapessero, per non delegare troppo a questi percorsi la soluzione di un problema che resta innanzitutto politico e sociale?
Ivan Pezzotta: Il primo limite è temporale, arriviamo tardi. Interveniamo quando la violenza è già entrata in modo tangibile nella vita delle persone. Il nostro lavoro è ridurre il rischio di recidiva, evitare che si ripetano comportamenti violenti con la stessa partner o con future partner, ma la situazione è già crollata.
Dobbiamo tenere bene a mente che, una volta che la violenza è apparsa, può ripresentarsi indipendentemente da noi. Possiamo fare il miglior lavoro del mondo ma non possiamo garantire che non ci saranno nuove violenze. Un percorso antiviolenza non è una certificazione di sicurezza, è una diminuzione del rischio, un elemento di controllo e monitoraggio in più.
Per questo è essenziale lavorare in rete con tutti i servizi coinvolti, centri antiviolenza, servizi sociali, forze dell’ordine, sanità. Solo così possiamo farci un’idea più realistica del rischio attuale di recidiva.
L’obiettivo dei percorsi è la sicurezza della donna attraverso il lavoro sull’uomo, ma con al centro la sicurezza della donna. Non vogliamo ulteriori vittime, né tra le donne che hanno già subito violenza né tra quelle che potrebbero diventarlo.
Il problema della violenza maschile contro le donne resta innanzitutto politico e sociale. Noi ci muoviamo dentro questo quadro, facciamo la nostra parte, ma non possiamo essere considerati la risposta risolutiva.
Responsabilità individuale e fattori culturali
Quando si parla di violenza maschile contro le donne è facile oscillare tra due estremi. Da una parte l’idea che tutto dipenda dal singolo, come se ogni storia fosse solo il frutto di una biografia sbagliata, di una fragilità individuale, di un carattere violento. Dall’altra una lettura tutta strutturale, che attribuisce ogni responsabilità al sistema patriarcale, alla cultura, alla società, fino quasi a far scomparire il soggetto concreto che agisce violenza.
Il lavoro di Pezzotta prova a tenere insieme questi due piani senza confonderli. Da un lato c’è la responsabilità piena, non negoziabile, dell’uomo che ha agito violenza. Nessun contesto giustifica il danno inflitto. Dall’altro c’è la consapevolezza che certi gesti non nascono nel vuoto ma dentro un sistema di ruoli di genere, di aspettative sulla maschilità, di copioni relazionali che rendono accettabile e a volte quasi normale esercitare potere e controllo sulla partner.
Il punto allora non è scegliere tra responsabilizzare l’individuo o criticare la cultura, ma riconoscere che una presa in carico seria deve lavorare su entrambi i fronti. Senza deresponsabilizzare l’uomo in nome del contesto e senza illudersi che basti il pentimento individuale se il modello di potere maschile intorno a lui resta immutato.
Per informazioni su CambiaMenti: https://www.cambia-menti.org/